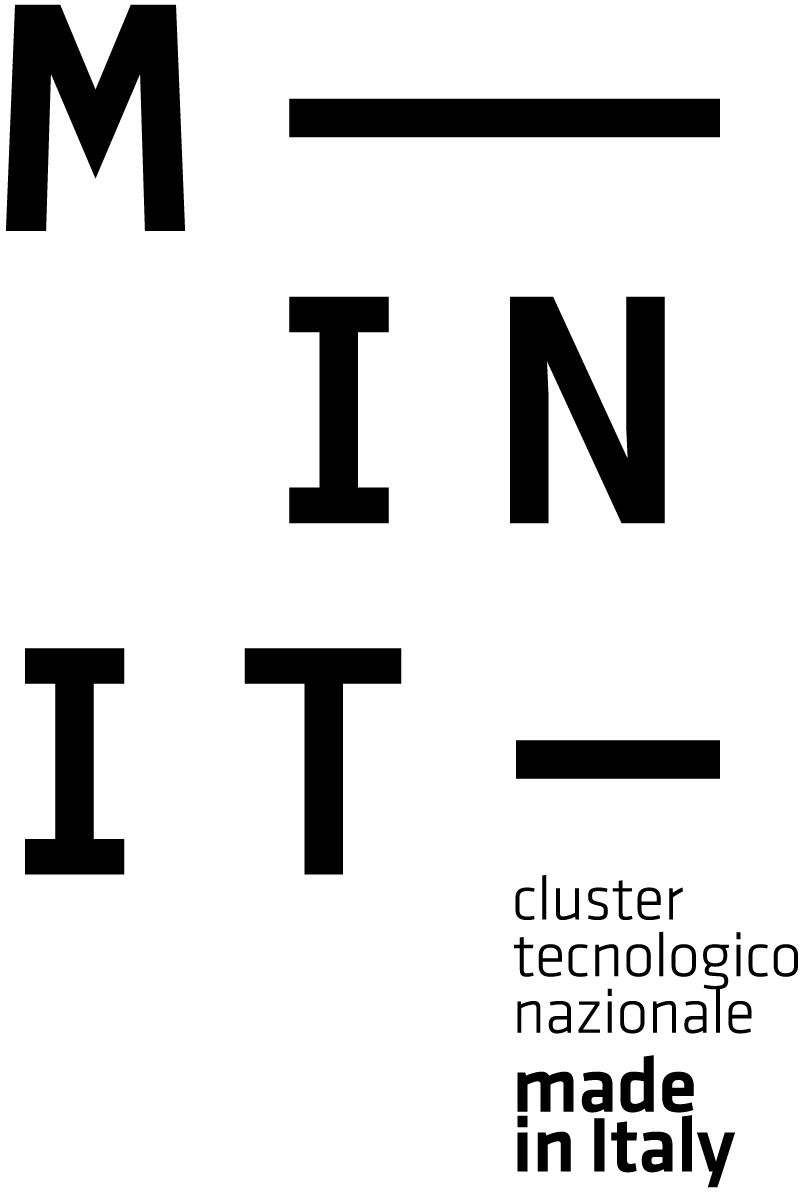Si è soliti dare un giudizio non positivo del livello di innovazione del nostro tessuto produttivo, e legare questo giudizio alla composizione dello stesso, caratterizzata dalla presenza di imprese troppo piccole. Un’analisi più attenta potrebbe aiutare, però, a fornire una lettura più corretta.
L’ultima rilevazione dell’European Innovation Scoreboard, lo strumento annualmente elaborato dalla Commissione europea per analizzare le prestazioni innovative degli Stati membri dell’Ue, rivela una tendenza italiana al rialzo che dura in sostanza dal 2014, l’anno della prima indagine europea. In questo periodo, a fronte di una crescita media continentale del 12,5%, il nostro Paese ha migliorato le proprie performance a un ritmo esattamente doppio: +25%. Un dato che l’ha posto tra quanti hanno fatto gli sforzi relativamente più rimarchevoli, addirittura meglio dei tradizionali primi della classe in questo ambito: i Paesi scandinavi.
Una scalata non indifferente, rispetto alla quale non può non essere riconosciuto un ruolo importante, se non fondamentale, alle micro e piccole imprese, universo troppo facilmente (e troppo spesso) accusato di ogni problema e di ogni arretratezza del nostro sistema produttivo.
Non si tratta di voler tirare l’acqua a nessun mulino in particolare. Basta compiere due osservazioni basate entrambe sui numeri. La prima è che in Italia la quota di spesa dei privati sugli investimenti complessivi in ricerca, innovazione e sviluppo, è costantemente salita negli ultimi anni e si è avvicinata a quella media europea. Nel frattempo è calata, invece, l’incidenza della spesa pubblica, in controtendenza peraltro rispetto ai Paesi “pari taglia”. Ma se è giocoforza mettere in collegamento il maggior impegno dei privati al miglioramento delle prestazioni italiane, è altrettanto obbligato evidenziare il ruolo di micro e piccole imprese in questo processo.
Nel nostro Paese le imprese che contano meno di 49 addetti (appunto le micro e piccole imprese) costituiscono il 99,3 per cento del totale, con il 62,6 per cento degli occupati e il 43,1 per cento del fatturato. Difficile che il colpo di reni italiano sul fronte dell’innovazione sia stato possibile senza il loro, forte, contributo.
I risultati raggiunti e quanto si è fatto per ottenerli sono apprezzabili, ma non bastano. Alla vigilia della crisi pandemica, l’Italia continuava a essere l’unico Paese europeo a non aver raggiunto i livelli di reddito precedenti la crisi finanziaria scoppiata nel 2008. Nonostante i segnali positivi del 2021, e, speriamo, la conferma della tendenza nell’anno in corso, è necessario uno shock positivo.
La cura più indicata è senz’altro una forte dose di innovazione: proprio l’innovazione incessante è il tratto caratterizzante del nostro tempo. Un deciso rilancio delle attività di ricerca e sviluppo può non essere l’unica soluzione, ma di sicuro può fare da locomotiva del convoglio. Purché le politiche a monte di questo processo, e ancora più la loro declinazione, si muovano in forte sinergia con il mondo delle imprese e in particolare, considerata la geografia imprenditoriale italiana, delle micro e piccole.
I risultati nella “classifica” dell’Innovation European Scoreboard sono anche il frutto degli strumenti pubblici attivati negli ultimi anni: dalla Nuova Sabatini al Super-ammortamento e al kit legato a Impresa 4.0. Un insieme che ha rappresentato un buon punto di riferimento, specie quando si è riusciti a coinvolgere il numero più ampio possibile di imprese, favorendo magari le micro e le piccole.
D’altro canto, la storia del nostro “Made in” sarebbe stata profondamente diversa se le piccole imprese non avessero posto un’attenzione quasi maniacale alla necessità di innovarsi costantemente, sia pure in maniera informale, soprattutto per adeguare prodotti e servizi alle esigenze del mercato. Più si alza l’asticella della competizione globale, però, più diventa complicato procedere in autonomia, come le micro e piccole imprese (lo ha rilevato una indagine della CNA) fanno nel 40 per cento dei progetti innovativi.
Come procedere, allora? Il World Economic Forum suggerisce qualche direttrice: “Migliorare l’innovazione richiede un ambiente favorevole. In particolare, investimenti sufficienti per la ricerca; la presenza di istituti di eccellenza capaci di generare le conoscenze di base necessarie per sviluppare nuove tecnologie; una fitta collaborazione fra università e imprese e un’adeguata protezione della proprietà intellettuale”.
Per seguire questo percorso è indispensabile un cambio di mentalità a tutti i livelli. A monte di sviluppo e innovazione c’è la ricerca, ma fare ricerca è costoso e il sistema imprenditoriale italiano non può permettersi, per la sua tipologia, una semina gravosa che va lasciata alle grandi strutture, pubbliche e private. Purtroppo, però, come spiega un documento pubblicato dalla “Harward Business Review – Italia” il nostro Paese sconta “un grave ritardo nel trasferimento tecnologico delle imprese”. Diventa necessario, pertanto, “costruire una rete organica per la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico qualificando e potenziando quanto di positivo esiste nel Paese”. Ad esempio, valorizzando la flessibilità italiana anche nell’innovazione, giusta combinazione tra abilità artigianali e conoscenza scientifica, abitualmente messa in pratica soprattutto nelle piccole imprese.
Le buone intenzioni rischiano però di infrangersi sulla scarsa capacità di dialogo tra istituzioni e micro e piccole imprese. Per facilitare questo dialogo, servono strutture di intermediazione che sappiano avvicinare e accompagnare le imprese alle strutture di ricerca e innovazione. Strutture che in realtà già esistono. Sono le associazioni di imprese come la CNA, da sempre vicina ad artigiani e “piccoli”; tradizionalmente in grado di avvertirne le esigenze; impegnata, spesso con successo, a connetterle con le istituzioni.
Mario Pagani (CNA, Vice Presidente Comitato Scientifico e della Formazione Cluster MinIt)